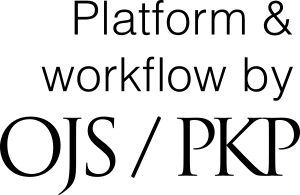Call for papers 2025
CALL FOR PAPERS – DOSSIERS 2025
Al fine di ampliare la portata e la qualità degli articoli scientifici pubblicati, il comitato editoriale della rivista Brazilian Journal of Criminal Procedure (Scopus, WoS, SJR Q2, Scielo, Dialnet, Qualis A1, Anvur A) indice la presente call relativa alla pubblicazione di un contributo scientifico in uno dei dossiers tematici indicati di seguito, che saranno pubblicati sui numeri della rivista del 2025, secondo la lista di temi, degli editori e delle scadenze così precisati:
|
|
Termine per la presentazione |
Periodo di valutazione e correzione |
Periodo stimato per la pubblicazione |
|
Vol. 11 n. 2 |
Mar. 23, 2025 |
Apr. and Magg. 2025 |
Giug. 2025 |
|
Vol. 11 n. 3 |
Lug. 20, 2025 |
Ag. and Sett. 2025 |
Ott. 2025 |
La presentazione dell’articolo deve essere effettuata sul sito web della RBDPP, indicando il dossier al quale il contributo è destinato. Qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento può essere trasmessa agli indirizzi: rbdpp.editor@gmail.com o vinicius.vasconcellos@usp.br. Il contributo deve rispettare tutte le regole stabilite dalle politiche editoriali e dalle linee guida previste dalla RBDPP per gli autori: la loro violazione costituirà causa di rigetto in via preliminare.
L'articolo deve essere originale, non deve essere già stato pubblicato e deve risultare compatibile con l’oggetto del dossier scelto; la lunghezza deve essere compresa tra 15 e 25 pagine; può essere scritto in portoghese, inglese, spagnolo o italiano; il file presentato deve contenere il titolo, l’abstract, le parole chiave (sia nella lingua prescelta per la stesura dell’articolo sia in inglese) e la bibliografia alla fine. Il contributo sarà poi sottoposto ad una valutazione che sarà realizzata attraverso un sistema di doppia revisione in forma anonima. Si accettano depositi prestampa.
Per conoscere le politiche della rivista, gli standard di integrità scientifica e le linee guida per gli autori è possibile consultare il seguente sito internet che può essere tradotto in inglese attraverso il menu presente a destra: https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/about/submissions.
Inoltre, in aggiunta alla specifica call realizzata con riferimento ai seguenti dossier, è sempre aperta la call con riferimento alla sezione generale della RBDPP.
- 11, n. 2 – “Estinzione del reato, assoluzione e funzioni dell’accertamento nel processo penale”
- Editori: Stefano Ruggeri (Università degli Studi di Messina, Italia) e Francesco Morelli (Università degli Studi di Messina, Italia)
- Sintesi: Il nodo problematico dei rapporti tra estinzione del reato e assoluzione è da sempre rappresentato dall’accertamento del fatto. Attorno a questo tema ancora oggi si addensano, da un lato, aspettative di risultato della macchina giudiziaria e, dall’altro, grovigli teorici difficili da districare con il solo supporto della normativa codicistica. Si tratta di un tema che riflette a un tempo sia l’aspettativa sociale di “giustizia” di fronte alla scelta dell’ordinamento di estinguere la punibilità del reato, sia soprattutto il diritto fondamentale di ogni persona cui sia stata imputata un’azione criminosa di veder riconosciuta la propria innocenza al cospetto di una giurisdizione che non è stata in grado di condannarlo. Per altro verso sembra apparire paradossale e dar luogo a contraddizioni teoriche il fatto che il processo si concluda con un accertamento di un fatto tipico antigiuridico e colpevole che non possa essere trasformato in condanna. Per queste contraddizioni, questo argomento ha probabilmente fatto proliferare molte declinazioni dell’accertamento, le quali si apprezzano oggi non solo all’interno dello stesso sistema penale ma anche nei rapporti tra questo e giudizi extrapenali e, ancor più, altre giurisdizioni nazionali e internazionali. Eppure, se si parte dalla presunzione di innocenza, l’accertamento dovrebbe essere uno e non aggettivato, e può essere rigorosamente qualificato solo in forza della regola di giudizio che lo sostiene. Ed invece, ne conosciamo svariate tipologie, al cospetto dell’estinzione del reato: accertamento in ipotesi, accertamento allo stato degli atti basati sull’assenza di una innocenza evidente, proscioglimenti con accertamento sostanziale del fatto. Queste variegate categorie servono, forse, anche a determinare un effetto della sentenza che dichiara l’estinzione del reato necessariamente incompatibile con la presunzione di innocenza ma, purtroppo, spesso preteso sul piano delle rilevanti implicazioni sociali: il riverbero dell’esito del procedimento, pur proscioglitivo, sulla dimensione sociale della persona, nel consesso lavorativo, nei rapporti futuri con le istituzioni statali e, finanche, talvolta, nel contesto storico. Si tratta di complesse costruzioni ‒ la cui tenuta teorica resta ancora da verificare, alla luce della presunzione di innocenza e della teoria generale del processo ‒ che nascondono l’esigenza di attenuare la profonda sensazione di fallimento del processo che la dinamica estintiva in taluni evoca. Esse forse affondano le loro radici in agenti patogeni resistenti in qualche misura alla presunzione di innocenza, e mirano a sabotare il riconoscimento dello status innocentiae, con la sentenza di assoluzione nel merito, di fronte a condanne, e non accertamenti, impedite. Oppure, si tratta di antidoti a valori spuri per la giurisdizione ma affermati dall’ordinamento penale il quale, prevedendo le cause estintive, disinnesca quella che per taluni è la funzione del processo impedendo la punizione di reati accertati o accertabili. Un conflitto di valori, dunque, in cui la posta in gioco è la tenuta delle posizioni soggettive dell’individuo al cospetto della giurisdizione penale? Oppure l’esigenza di un riassetto teorico che renda i rapporti tra estinzione del reato e assoluzione più nettamente definiti da un uso chiaro e geometrico della regola di giudizio? Oppure ancora ‒ sconfinando nel terreno della politica criminale ‒ l’esigenza di dar un’eco extrapenale all’accertamento sostanziale che regge la decisione di estinzione per permettere conseguenze giuridiche ad accertamenti di fatti penalmente illeciti non più punibili? La problematica in esame rivela quindi una portata dall’enorme rilevanza teorico-sistematica ed applicativa, sollevando interrogativi cui in prospettiva nazionale e soprattutto comparatistica è rivolto il presente dossier.
- Termine per la presentazione dell’articolo: 23 marzo 2025;
- Periodo di valutazione: Aprile e Maggio 2025;
- Periodo previsto per la pubblicazione: giugno 2025.
- 11, n. 3 – “A Comparative Analysis of Negotiated Justice Systems”
- Associated-editors: Giulia Lasagni (University of Bologna, Italy) and Jacopo Della Torre (University of Genova, Italy)
- Deadline for submissions of articles: until September 20, 2025;
- Period of evaluation: October and November, 2025;
- Prediction for publication: November and December, 2025.
-
Summary: Until a few decades ago, it was widely believed that, due to its construction in accordance with the principles of the mixed (inquisitorial) model, criminal trials in continental Europe and Latin America were inherently incompatible with consensual procedures for terminating proceedings. On this view, negotiated justice was traditionally seen as a phenomenon intrinsic to adversarial systems rooted in common law jurisdictions—such as the United States, the United Kingdom, Canada, or Australia.
Today, however, this dogma has been decisively challenged. Across many Romano-Germanic legal systems, various forms of negotiated resolutions have rapidly proliferated, marking what can only be described as a global shift—one that has not bypassed continental Europe and Latin America. Increasingly, civil law jurisdictions are codifying mechanisms in which the resolution of the criminal conflict becomes the object of “negotiation” between the parties—and in some cases, the court itself—in order to reach an agreement. In parallel, several countries, such as Austria, Slovenia, and Portugal, have witnessed the rise of informal negotiation practices, not explicitly provided for by statute but developed and stabilized through prosecutorial and judicial praxis.
Moreover, growing attention is being paid—both in legislation and legal doctrine—to informal and hybrid forms of negotiated justice, which lie at the intersection of discretion, procedural simplification, and restorative practices. These models often escape traditional classifications but play a crucial role in shaping the daily operation of criminal justice systems. The role of informal mechanisms—whether as transitional tools, pragmatic responses to systemic overload, or expressions of a shifting penal culture—deserves particular scrutiny, especially in relation to the risks of opacity, inequality, or uneven application of guarantees.
Other systems have gone further. In France, for example, the scope of plea bargaining has been expanded to include more serious offenses. In Germany, following decades of debate, the legislature has codified an existing informal practice in the form of the Verständigung, a negotiated procedure formally applicable to all categories of offenses. What emerges from this evolution is the growing recognition that a distinctive phenomenon—what we might now call European negotiated justice—is taking shape. While legal frameworks differ, a variety of national "styles" or "models" of plea negotiation are developing, each reflecting local legal culture and procedural values.
This call for papers invites contributions that explore negotiated justice in criminal proceedings from a comparative perspective. Papers may focus on a single national system or adopt a broader, cross-border or theoretical approach. The following themes are particularly welcome:
- The historical development and the diffusion of negotiated procedures across the world, and the emergence of distinct models of plea bargaining;
- The problematic relationship between negotiated justice and criminal evidence, including the role of the standard of proof and the principle of truth-seeking;
- The implications of plea bargaining for the fundamental rights of both the accused and the victim, including issues of consent, equality of arms, and judicial oversight;
- Key judgments of the European Court of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights relevant to plea agreements, and soft law instruments adopted by the Council of Europe addressing negotiated justice;
- The implications of forms of negotiated justice on sanctioning models;
- The contribution of the EU Directives on procedural rights to the development of fair and balanced consensual mechanisms in criminal proceedings;
- The role and limits of negotiated justice within the framework of the European Public Prosecutor’s Office, particularly in light of Article 40 of Regulation (EU) 2017/1939;
- The intersections between negotiated justice and procedural sanctions;
- The emergence and legal treatment of informal and extra-codified practices of negotiated justice;
- The challenges posed by the mutual recognition of judgments resulting from negotiated agreements in the Area of Freedom, Security and Justice, including issues of equivalence, trust, and due process in cross-border enforcement;
- The repercussions of negotiated justice on the right to an effective remedy and potential impact the occurrence of miscarriages of justice;
- Enforcement of negotiated justice: empirical analysis of data emerging from the practice.